
- 16 film per capire l’Africa (2 per non capirla) - Dicembre 9, 2024
- Alla ricerca dell’egemonia culturale perduta: da Claudio Villa a Luigi Nono - Giugno 28, 2024
- AUTOBAHN 9: «Verso i Mari del Sud» - Maggio 7, 2022
La creatività nel nostro paese è sempre stata penalizzata a favore di una più rassicurante omologazione. I tempi sono cambiati, mi dirai. Sì, ti dico io. Perché noi li abbiamo fatti cambiare senza opporci a imbarbarimenti di linguaggio o conformismi. L’Italia è sempre stata una colonia culturale, soprattutto nell’ambito della musica jazz e dintorni. Noi dobbiamo valorizzare la poetica della sillaba come centro musicale del vocabolo. (Guido Mazzon)
Conosco Guido da diversi anni e ogni giornata che passiamo insieme si riempie di conversazioni senza rete che riescono sempre a mettere insieme le cose di cui ci piace parlare: l’improvvisazione, il free, la sinistra e altri dogmatismi. In certi casi ho registrato quei discorsi che, inevitabilmente, sono diventati interviste con una notevole profondità di campo. Quella che segue è l’insieme di due diverse conversazioni che abbiamo avuto tra il 2014 e il 2016. Anche se lo spaccato può essere sufficiente a descrivere un personaggio complesso, intrigante e forse per alcuni anche scomodo, sono convinto che i nostri dialoghi non registrati andranno avanti ancora per molti anni, tra una bonarda e un buon piatto di tagliatelle.
Protagonista del free italiano con il suo Gruppo Contemporaneo e della musica creativa europa accanto figure di spicco come Alexander von Schlippenbach, Misha Mengelberg o Radu Malfatti, partner di afroamericani del calibro di Lester Bowie, membro per un lungo periodo dell’Italian Instabile Orchestra, Guido Mazzon è oggi un musicista libero di spaziare tra reading di poesia, convegni su Pasolini (di cui era cugino) ed escursioni nel jazz contemporaneo come nel recente Neu Musik Duett assieme a Marta Sacchi.
Mi ero segnato alcuni nomi per iniziare questa intervista: il primo è Johann Sebastian Bach. Volevo sapere perché per te è così importante.
«Quando da ragazzino passai dalla musica di New Orleans al bebop, trovai immediatamente una relazione tra quel fraseggio e quello bachiano [canta una frase, ndt] prescindendo ovviamente dalle note e dalle modulazioni. Penso che, ascoltato superficialmente, Bach dia una sensazione di compiutezza e di serenità immensa, ma è anche estremamente pedagogico, anzi, la sua genialità è di insegnarti mentre fa dell’arte. Mi appassiona la sua musica per strumento solo, perché per me è più leggibile e più praticabile. In un mese ascolto diverse volte le Suite per violoncello, analizzando le partiture e facendo delle trasposizioni per tromba, a volte in tonalità originale, a volte trasponendo per ragioni di estensione. Trovo sempre delle risoluzioni armoniche inusitate e molte volte mi chiedo se alcuni accordi jazz non fossero già presenti in Bach in una forma diversa. Questi strani scarti che si possono trovare nel jazz o nell’improvvisazione jazz, secondo me erano già presenti in Bach e per percepirli non basta ascoltarlo, bisogna trascriverlo e suonarlo, cioè cercare di leggerlo e interpretarlo».
È un autore che ti sei portato dietro tutta la vita?
«Assolutamente. Il maestro per il fraseggio veloce è lui, ma anche per quello lento: ci sono alcune sarabande che, se cambi la pronuncia e ti prendi qualche libertà, sembrano delle balland suonate da Chet Baker».
Quanto credi che sia condivisa questa idea nel mondo del jazz?
«Non molto, anche perché credo che da parecchio tempo il jazz sia diventato una musica di imitazione: è pieno di codici e archetipi, che possono essere il fraseggio di Charlie Parker, quello di Dizzy Gillespie o perfino quello di Lennie Tristano (anche se lui si spostava leggermente). Io stesso ho sempre pensato a Tristano come a uno strano Bach, molto più liquido ed espanso. Ma diciamo che in generale, se parli con un jazzista a livello superficiale, lui dirà che il musicista più vicino al fraseggio del jazz è Bach, non certo Mozart e non certo Monteverdi. Mentre, per quanto mi riguarda, il discorso deve essere invece ampliato anche ad altri compositori. Torno quindi decisamente in Italia e dico che, dal punto di vista lirico, sono importanti anche Monteverdi e tutta l’opera italiana, da Donizetti a Verdi, che un tempo nel jazz pareva essere troppo popolare a causa dei suoi intervalli entusiastici e patriotticamente esposti».

Nel jazz pensi che esista quindi una pronuncia italiana?
«Ti racconto una cosa che mi è sempre rimasta molto impressa. Quando suonavo con la Globe Unity negli anni ’80 in Germania o nei festival organizzati dalla FMP a Berlino, qualsiasi cosa io facessi, tutti mi dicevano che avevo un suono molto italiano. La cosa mi faceva piacere da una parte, anche se mi chiedevo cosa mai intendessero per italiano. Credo una certa predisposizione lirica, perché in quell’ambito non si giocava molto di intervalli, ma con note molto parche, buttate nell’insieme del magma creativo. Quel collettivo senza direttori era basato appunto sulla spontanea creazione e sul tenersi in ascolto l’uno con l’altro. Il gioco di intervalli però mi è sempre rimasto in mente. Un tempo dicevo che la prima nota è la più importante perché ti indica il cammino, però quella ancora più importante è la seconda. Cosa faccio? Un intervallo, che sia piccolo o ampio.
Tempo fa mi ero appassionato di un libro di Gino Stefani sugli intervalli musicali associati ad alcuni stati d’animo. Consciamente o inconsciamente la seconda nota è l’espressione del tuo stato d’animo. In alcuni brani di uno dei lavori recenti ho esasperato questo concetto. Non a caso mi è venuta in mente una canzone di Endrigo, Io che amo solo te, che inizia con un famoso intervallo di sesta. Quella mi ha rimandato a Libiamo ne’ lieti calici di un tal Giuseppe Verdi, per poi arrivare a un Buonanotte fiorellino di un cantautore molto noto».
Stiamo parlando di “Apro il silenzio” (Setola di maiale, 2014), un progetto che hai condiviso con Nicola Cattaneo (chitarre), Franco Cortellessa (chitarre), Giorgio Muresu (contrabbasso) e Stefano Giust (batteria). Questo organico, che poggia sulla presenza delle chitarre, sembra suggerire più un’organizzazione di tipo contrappuntistica piuttosto che semplicemente armonica.

«Sì, in un certo senso. Del resto ho sempre cercato di coniugare l’improvvisazione tout court con la composizione cosiddetta “tematica”. Quando si improvvisa non si deve concedere assolutamente nulla alla fraseologia o ai terribili patterns. Si deve creare un racconto. Ma non stiamo parlando di linguaggio, perché per me la musica non lo è affatto. È semmai un insieme di segni che rendono narrativa la musica. In questa esperienza succede che da composizioni piuttosto aperte, nelle quali i musicisti hanno parti obbligate, conduco l’interpretazione della composizione, ovvero ricompongo in tempo reale il pezzo, tenendo conto dell’interpretazione dei singoli e dell’interplay che tra di essi si instaura».
Questa conduzione interviene anche su agoniche e dinamiche?
«Sì, in un certo senso succede ciò che viene indicato in“Bitches Brew”, cioè “directions in music by Miles Davis”. Lui non aveva portato dei pezzi di carta definiti, ma conduceva la musica in vario modo. Per fare questo, senza perdere troppo tempo, ci vuole la notazione musicale con delle parti anche aperte, molta attenzione e ascolto».
Voi da dove siete partiti?
«Da alcune notazioni scritte nelle quali le parti aperte non erano definite, come “open” o scatole sonore, ma sorgevano dall’urgenza di qualcuno dei musicisti che, in un certo momento, dimostrasse di voler prender in mano il testimone del racconto. Non necessariamente dove c’è scritto “impro”, come nelle classiche situazioni jazzistiche con le misure contate (oppure negli “open” come nel free jazz o nelle strutture di Ornette). In mezzo a queste strutture elastiche le improvvisazioni dei singoli non vengono da me necessariamente indicate. A volte il solista del momento si prende la sua responsabilità e sposta il discorso. La creatività del gruppo nasce da questa libertà di trovare le proprie vie d’uscita. Una cosa di cui tu mi parlavi a proposito di Paul Bley e che mi ha fatto molto piacere».
…quando trovi una via di uscita la imbocchi.
«Esattamente. Questo vale per me che, in quel caso, avevo la funzione di dare la direzione, anche in virtù del mio strumento che è più esplicito di tanti altri in un contesto analogo. Quando trovo il pertugio in cui infilarmi non me lo lascio scappare. La creatività del gruppo nasce dalla libertà di trovare le proprie vie d’uscita. Questo è ciò che rende la musica più viva. La composizione così scaturisce da un’idea strutturale, ma diventa patrimonio di tutti attraverso il contributo di ciascuno. In altri tempi questa l’avrebbero chiamata una musica democratica, che è ciò che mi interessa, perché dirigere un gruppo di orchestrali non mi dà assolutamente nulla. Io voglio che ciascuno faccia propria quella frase per esprimere se stesso».
Un’idea abbastanza antica, in fondo.
«Sì, è quella che è sempre stata alla base del cosiddetto free jazz, anche nei suoi momenti più farraginosi. Se pensiamo all’Art Ensemble of Chicago, c’erano dei temi più o meno definiti, ma anche molte aperture e stravolgimenti, che trasmettevano però l’idea di una musica che si muove e non si ripete».
Cosa ti rimane dell’esperienza con l’Italian Instabile Orchestra?

«Per me è stato un momento di autodisciplina, dato che mi sono trovato seduto tra altre due trombe a eseguire delle parti. La mia libertà mi è stata limitata ed è stato anche un bene. È stato molto piacevole far parte di un contesto più ampio, pur con delle strutture ben definite, visto che, quando si allarga il numero dei musicisti fino a 18 o 19, la codificazione deve essere sempre più rigida. Stretto quindi nell’ambito di sezione, non potevo fare a meno di personalizzare le note che suonavo, assumendomene la responsabilità – cosa che poteva piacere o meno. In un background strutturato o magmatico, cercavo di cogliere degli spazi in cui far fluttuare qualche mia fantasia musicale».
Un altro musicista a cui sei molto legato è stato Giorgio Gaslini.
«Io e Giorgio siamo stati molto amici, c’era una notevole affinità tra noi e, a parte il fatto che si chiamava come mio padre e gli assomigliava anche molto, sono stato uno dei pochissimi suoi non-allievi, dalla Scuola del Testaccio al Conservatorio o semplicemente tra i musicisti che avevano suonato con lui. Per me infatti era un collega con cui si poteva parlare di musica, criticare certi luoghi comuni e anche ironizzarci sopra. Ci univa una certa cultura di ampio respiro, cosa che non spesso si ritrova tra i musicisti: potevamo parlare di arte, letteratura, pittura e musica. Ho sempre apprezzato il grande coraggio del suo concetto di musica totale, codificata forse in modo leggermente dogmatico, nel suo libretto entusiastico uscito negli anni Settanta. Anche io non vedo perché la musica non debba essere totale.
Ad esempio perché una mia improvvisazione free non può citare una canzone di Nilla Pizzi? Una cosa del genere in tempi passati veniva presa come un mio vizio per la citazione o, addirittura, come una provocazione. Cioè: ci stai prendendo in giro suonando un temino banale in un contesto caotico. Su queste cose, invece, io e Giorgio ci incontravamo, anche se in un modo diverso. Con lui, che non ha mai arrangiato, ma semmai ha sempre ricomposto, scherzavo dicendogli che in “Canto ritrovato” aveva ripreso Il bell’uselin del bosco. In realtà lo aveva trasformato esattamente come Dollar Brand avrebbe potuto trasformare una canzone popolare sudafricana. In questo sono sempre stato d’accordo con lui».
Usciamo per un attimo dal percorso musicale parlano di tuo cugino, tal Pier Paolo Pasolini. Anche questa è un’attività che ti vede coinvolto in prima persona tra incontri e convegni dedicati al poeta. Come pensi che venga considerato PPP in questi anni?
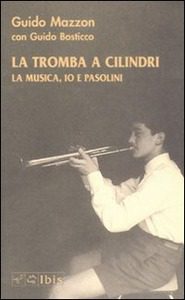
«Su Pasolini ci sono diversi gruppi e chiunque ormai lo cita, a volte sparando anche delle cazzate. Si tratta di un personaggio molto complesso. Se uno l’ha conosciuto di persona, se ha approfondito o, come nel mio caso, lo conosce anche il punto di vista famigliare, visto che le nostre nonne erano sorelle, allora può fare un’analisi sia esterna che interna. Per me è soprattutto un fatto affettivo. Come raccontavo ne “La tromba a cilindri – La musica, io e Pasolini” (Ibis, 2008) a 11 anni avevo una tromba ciofega e lui mi diede un assegno di 50mila lire che allora era un’ira di Dio. Avvenne a Casarsa, dove lui era passato per salutare la madre nella casa che ora è diventata la sede del Centro Studi Pier Paolo Pasolini».
Con lui hai mantenuto il rapporto anche da grande?
«Sì, sempre con quella soggezione che può esserci tra un ragazzo e un adulto. Quando andavo a Roma a trovare sua madre lo vedevo sempre indaffaratissimo. Io però stavo a Milano e lui ci veniva raramente perché non gli piaceva tanto. Ha scritto un romanzo, pubblicato recentemente, “La nebbiosa” (non molto bello in realtà), nel quale parla della banda del Giambellino e della mala. Ecco, per chiudere, essendo abbastanza informato dei fatti, sono stato convocato anche nella riapertura del processo».
Convocato per cosa?
«Al RIS di Roma per assistere alla riapertura dei reperti criminologici della notte in cui è stato ucciso. Abbiamo repertato una maglietta insanguinata e altre cose. È ancora tutto conservato. Fine. Archiviato. Non so, è come se tu mi chiedessi chi ha fatto la strage di Bologna o piazza Fontana: mistero!».
Finiamo con due tuoi lavori recenti – “Lo spazio della musica – Pensieri e Immagini” (Apollo, 2016), un libro che accompagna alcune tue poesie alle delicate immagini di Marta Scacchi e il disco “Sounding Lines” del Neu Musik Duett, sempre con Marta al clarinetto, pianoforte ed elettronica (Setola di Maiale, 2016). In entrambi i casi si cercano contatti tra linguaggi differenti: ovvero un rapporto intimo tra parola, immagini (video o fotografie) e musica.

«Sì associamo poesie, immagini e musica; sono le parole che riguardano la musica o, se si preferisce, partiture musicali. Nel duetto con Marta Scacchi la composizione all’istante è particolarmente forte. Alcuni brani partono da un suo video che funziona come una partitura visiva, cioè non nel senso di una sonorizzazione, bensì come trasformazione di linguaggi: da visivo a musicale. Quindi parlare di improvvisazione è estremamente riduttivo. In altri casi il punto di partenza è stata una fotografia di Marta. Anche in quel caso è ciò che guardiamo a suggerirci l’idea compositiva, non la suggestione. Infine anche la presenza dell’elettronica crea un’indicazione sulle note da eseguire. L’ultimo elemento compositivo è la famosa improvvisazione tematica. Suonando in due si fa circolare l’idea di un tema, che può essere armolodica in un senso colemaniano: sovrapponi melodie ottenendo così delle armonie. È esattamente quello che facciamo noi. Contrappuntare qualcuno significa inevitabilmente creare armonie o giocare sugli intervalli. Tutto questo per dire che bisogna distinguere questa modalità, dall’idea di improvvisazione totale – cosa che per me non significa nulla. Nemmeno Evan Parker o Cecil Taylor la fanno. Sono più d 40 anni che seguono un loro discorso che mi coinvolge moltissimo, ma più codificato di questo cosa c’è? Quando si mette lì, cosa fa Taylor? Compone o improvvisa? Io dico che fa la musica. Che l’abbia composta o improvvisata non fa differenza. Anzi, forse si è solamente risparmiato il tempo di scriverla».
Il discorso si complica quando si mettono insieme personalità diverse.
«Sì, soprattutto se le personalità non sono collegabili tra loro, perché se sento Cecil Taylor e dobbiamo interagire non ho nessun problema, se io e Marta ci mettiamo a improvvisare ci conosciamo e lo facciamo. Se invece trovi quell’altro che fa il jazz e non trova lo swing, allora dico semplicemente che stiamo facendo altro. Anche lui sta improvvisando, ma lo fa sui pattern, noi sopra suggestioni di altro genere, ad esempio, dopo un ascolto di Edgar Varèse. Allora l’improvvisazione diventa l’atto finale di un processo culturale molto denso. Mentre nel jazz va bene quasi tutto. Nell’improvvisazione come la concepisco io ci sono delle maglie assolutamente strette. Ci sono delle cose che quando non vanno, non vanno. Il racconto non c’è. Invece quando funziona, lo fa con una forza che molte volte nemmeno i compositori riescono a raggiungere, a meno che non siano dei grandi. Capita allora che commentiamo un’improvvisazione chiedendoci se non abbiamo raccontato troppo oppure non abbiamo raccontato nulla, oppure invece se c’è stato il racconto che per me significa: c’è stata musica».
novembre 2017 © altremusiche.it

Lascia un commento